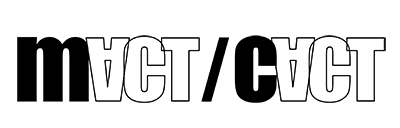POST.PAYSAGES.
Matti Basis / Serge Brignoni / Jon Campbell / Carmelo Cutuli / Oded Feingersh / Debora Fella / Yona Lotan / Federica Pamio / Carlo Alberto Rastelli / Liu Yujia
A cura di Mattia Desogus
16 maggio - 10 agosto 2025
Il discorso paesaggio comincia ad articolarsi nel mondo dell’arte con un interesse crescente dalla fine del ’600. Nel campo figurativo matura nell’artista l’estetica della rappresentazione del campo visivo e si fa viva quasi una necessità, o una pratica devozionale, nel rappresentare un bosco, le nuvole o una distesa d’acqua. Quel sentimento, che mosse l’arte fino al trionfo dell’età romantica, va necessariamente ricercato nella volontà da parte dell’artista di includersi in quell’immensità, in quell’infinita perfezione che domina gli eventi. È propria dell’800 la meditazione totale dell’essere umano nei confronti della natura con una capacità artistica, che finalmente supera i virtuosismi descrittivi dell’arte fiamminga per mettere al centro l’uomo, e dunque l’artista, minimizzato e impotente, al cospetto dei fenomeni naturali estremi. Proprio quelle pennellate partecipano ai turbinii del sublime, caricando il gesto artistico di impeto e trasmettendo il sentimento sulla tela per coinvolgere e travolgere, in un mutamento totale che la pittura non abbandonerà più.
Sentimento, dunque.
Se dovessimo abbandonarci oggi a delle allusioni sulla trasformazione del dialogo artista-paesaggio, parleremmo di post-paesaggio. Dagli anni immediatamente successivi ai conflitti mondiali l’artista, ereditando una scena paesaggistica mutata e in progressivo sconvolgimento, ha imparato a rileggere le esperienze precedenti, riuscendo ad immedesimarsi nello spazio, rievocando gli stessi sentimenti dei suoi predecessori. Per citare lo scritto di Michael Jacob, “il paesaggio è un’esperienza di sé”. Non può che essere questo il principio della ricerca. La percezione dello spazio, magari semplicemente aprendo una finestra su un giardino o contemplando la complessità di un fiore, continua ad evocare il sublime attraverso quei misteriosi giochi della memoria. Per alcuni anche un risveglio del lato spirituale che guarda al creato.
È Calvino a ricordarci che la natura può essere anche ostile e spesso può avviare una sensazione di spaesamento se non di pericolo; un’ostilità riconducibile in primis alle conseguenze delle azioni umane sul territorio.
Oggi più che in passato ci si confronta con i cambiamenti dell’antropizzazione, che svincolano tra inevitabili e leziosi tentativi di tutela del paesaggio per arrivare ad un’immotivata colpevolizzazione delle proprie azioni.
Persino lo spazio urbano non è estraneo a queste generazioni/degenerazioni della mente. La città di oggi non fagocita più l’uomo che ha invece imparato a diffidarne, a viverla accettandone l’invivibilità.
Natura e città, da sempre distinte, tornano sul medesimo binario e si confrontano sui loro apporti benefici sull’individuo. Non due organismi separati dunque, ma complementari uno all’altro, bonari e malevoli, insidiosi ed accoglienti al contempo. E sulla dicotomia pieno/vuoto ritorna in modo pertinente Calvino: “Ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone” (da Italo Calvino, Le Città Invisibili, 1972.)
È la nostra coscienza, e quella degli artisti, che si adatta a nuove ideologizzazioni del bello, ad un’estetica differente ma non necessariamente di più scarso coinvolgimento emotivo.
Mattia Desogus, 2025.
Carmelo Cutuli (1974), Caprone, 2013. Gesso, 35 x 21.5 x 10.5 cm, firmata Cutuli a impressione sul retro della scultura in basso al cx. Collezione privata, Svizzera.
Dove
MACT/CACT
Museo e Centro d’Arte Contemporanea Ticino
Via Tamaro 3
6500 Bellinzona
Orari
Venerdì, sabato, domenica
14:00 – 18:00
Ingresso
CHF 6.00