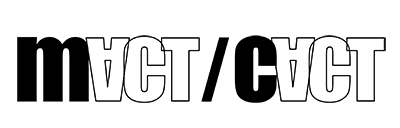La Famiglia. The Leaving Room.
Maurizio Anzeri / Katia Bassanini / Daniel Bolliger / Nniet Brovdi / Andrea Crosa / Federico Gallo / Francesca Guffanti / Alex Hanimann / Elke Krystufek / Gianluca Monnier / Gunnar Müller / Mattia Paganelli / Carlos Quiroz / Massimo Vitangeli / Supersober Bohdan Stehlik / Una Szeemann / Franco Vaccari
A cura di Mario Casanova
Ex Tiscanova, Locarno. 30 luglio - 30 settembre 2006
A Christiane K.
Testo incompiuto e autobiografico per una mostra di Locarno
[…] So soltanto che era una donna intelligente trovatasi in questa situazione solo per la logica del sistema in cui viveva. […] (0)
Attorno a La Famiglia. The Leaving Room.
[…] Forse l’aspetto più significativo e creativo del mio lavoro è l’ambivalenza come tale… L’oggettività non ha molta importanza per me: tutto è oggettivo così come tutto potrebbe essere soggettivo… […] (1)
Immaginiamo un luogo dove esista anche dell’arte – non uno spazio definito “d’arte” –, una geografia dove tutto potrebbe rivelarsi, cominciando da noi, noi stessi, individui, dalla parte di chi (si) vede, da ciò che si manifesta nello spettatore che insegue sensualmente nell’ “oggetto” che lo circonda il “soggetto” in esso rifranto; laddove il libero arbitrio è dolore, piacere e redenzione; e tutto ciò che possiamo, ma vorremmo essere. Un territorio in cui l’io e il sé non si debbano sentire del mondo, bensì librarsi nel mondo, in equilibrio, cadendo i veli, le pietà e un nostalgico rimorso. Un luogo, nel quale non v’è spersonalizzazione o scuola della personalità, dove l’affermazione del concetto perde ogni suo valore venale, e la creatività e l’atto creativo si liberano finalmente dal vincolo dell’effimero tecnologico, estetico, e della manipolazione di massa versus l’individuo [noi], il singolare. Un luogo dove l’“immaginario collettivo” è un epitaffio che nasconde l’intimo segreto del desiderio, e il concetto di “tutto” supera ogni possibile immaginazione reale o riflessa, qui e ora. Un particolare orto, in cui il rapporto tra diritti e doveri non cerca, né trova alcuna corrispondenza nella realtà visibile.
Questa importante linea di “confine” per un sempre inedito accostamento a una diversa interpretazione della realtà e della verità attraverso la lente della nostra capacità e consapevolezza percettiva.
Descrivo una geografia reale e uno spazio teatrale, in seguito una verità mentale, poi architettonica, in cui il modello di storia dell’arte – o genericamente storiografico e di presentazione museale – non si ribella alle emozioni oppure non prevarica su di esse. Dove l’accezione concettuale e l’intelletto non costituiscono una forzatura, né un dogma, una dittatura o un fattore condizionante. Purché deviante. Mi piace ricordare, del 1927, il teatro magico… non per tutti… solo per pazzi… descritto da Hermann Hesse nel suo Der Steppenwolf. Un narrato fantastico e inquietante che ci riporta – giustamente – su di una linea di confine, appunto, quasi limbica; quella striscia spazio-temporale tra le due grandi guerre, allorquando follia e ragione, modelli e comportamenti sembravano fondersi indistintamente senza un apparente ragionevole ordine; e quando anche un impegno morale ed etico non apparivano come indispensabili. Quel punto, in cui psiche e ragione trovarono un disperato e delirante motivo di dissenso. Cosa è causa? E cosa è effetto? Cosa è allegoria, cosa allucinazione? Come si applicano – appunto – diritto e dovere? Riescono l’artista e il curatore a dare ancora una forma al pensiero e alla creazione artistica, alle verità assolute, per quanto manchino oggi i presupposti per una teorizzazione?
Una linea del confine dove si confrontano l’obbiettivo e il soggettivo, il pubblico e il privato, concetto e sensorialità, odio… e paura di perdere. Il luogo di transizione da una visione collettiva, mistificata, a un’altra più consapevolmente inconscia, intima e intimista.
[…] Ci sono dei matti che osservano le facce e i comportamenti della gente. Non perché siano epigoni di un positivismo lombrosiano, ma perché conoscono la semiologia. Sanno che la cultura crea determinati modelli, che questi modelli influenzano il comportamento, che il comportamento è un linguaggio e che, in un momento storico in cui la lingua parlata si irrigidisce sempre più nel convenzionale, diventando completamente sterile (leggi: tecnica), il linguaggio del corpo acquista sempre più importanza. […] (2)
e ancora
[…] Possibilità personali e individuali a parte, sono sempre la forza della logica e la debolezza delle contraddizioni di un sistema che decidono e producono in parte certi comportamenti. […] (3)
Pier Paolo Pasolini si riferisce a una emozionalità da contrapporre, come espressione liberatoria – il corpo come linguaggio –, alla comunicazione criptata e codificata dalla tecnologia, tecnica e tecnologizzata in generale.
Parlando di Body Art e di tutti i suoi aspetti performativi, Luigi Meneghelli ancora scrive:
[…] Ma la questione non sta solo nel verificare l’irruzione dell’opera nel presente quotidiano, il dissolversi del gesto artistico nel gesto banale, quanto nel notare, in questo, l’invariabile implicazione del corpo in quanto segno primario, indizio di un ritorno alle radici della vita, al grido, al respiro, all’orgasmo. […] Si dà una coincidenza tra identità ed espressività elementare, tra essere ed azione, tra coscienza di sé e sensibilità senza riserve. Ma ciò non comporta necessariamente la conquista di un corpo autentico (rivelatore della verità del soggetto) o di un corpo liberato (dalle strutture e dai codici del sociale), quanto piuttosto di un continuo esame della realtà obiettiva del corpo, di una esigenza esplicita di sapere quale è l’essere della sua realtà. (4) E non è un caso che il corpo come linguaggio (come festa, rituale, passaggio all’atto, violenza, pulsione, ecc.) si evidenzia nei momenti di disagio, di malessere, di minaccia: cioè, quando è necessario riconsiderare nuove percezioni del mondo, nuove posizioni di vita. […] … un approccio al corpo che (negli anni ’60-’70) si pone quale esibizione effimera del soggetto e affermazione di una identità sempre elusiva, transitoria. […] (5)
Per ritrovare, forse, una condivisione empatica tra soggetto e oggetto.
L’erezione di un metareale “salotto della psiche” – quasi una privata ambientazione installativa domestica titolata La Famiglia. The Leaving Room – è stata pensata, tracciando un (di)segno curatoriale ben definito sulla base dei criteri sopra elencati. L’impostazione sottende la mise en scène con accezioni fortemente performative dialoganti con l’intima e individuale percettibilità dello spettatore. La personalità del curatore non si limita ad arredare uno spazio, egli indaga piuttosto le molteplici possibilità di presentazione di opere, del loro contenuto e del valore dell’espressione artistica, confrontando il pubblico con i suoi vari significati e con le diverse modalità di lettura. [L’osservatore ha la sua propria consapevolezza – pure quella di capire di non capire.] Ciò avviene anche attraverso la sua [del curatore] personale utilizzazione dell’area espositiva a disposizione; quasi sempre l’espressione poetica di infiniti concetti universali entro i limiti finiti di una geografia fisica e temporale, un cubo architettonico.
La famiglia come luogo di nascita, di divisione e allontanamento. Un sistema nel sistema. Difficile la convivenza, non meno laborioso il distacco.
Certezze, intuizioni, stati alternati di impegno e disperazione sociali, e anche molti preconcetti, sono alcuni dei motori propellenti della creazione artistica, sottoposta – prima ancora della cosciente reversibilità evolutiva – a un processo necessario di sempre maggiore soggettivizzazione.
“Globalizzazione”, “international style” o “vetrina dell’arte” sono concetti che rientrano in misura sempre minore nelle premesse del curatore, via via che la consapevolezza di definire una linea stilistica/concettuale fondamentale e la sua storicizzazione viene meno. Simile riflessione andrebbe fatta attorno al luogo d’arte e alla sua utilità.
[Questa proposta espositiva è stata realizzata a Locarno, in Svizzera, durante l’estate 2006 nella sede di(s)messa di una tipografia artigianale/industriale di tipo famigliare, un luogo di attività commerciali legate all’immagine da marketing, di diffusione e duplicazione di flyer e gadget aziendali. Tale mio insediamento ha rappresentato una sorta di recupero e archeologia industriali. L’esposizione s’iscriveva in un progetto banalmente denominato Kunsthalle?, che poneva anche – per quanto mi potesse riguardare – quesiti importanti sulle opportunità esistenziali di uno spazio d’arte (contemporanea) nel sud della Svizzera.]
La decadente fatiscenza del contenitore – costituito da una sala al piano terra, una seconda stanza al 1° piano dello stabile, più altri “non-luoghi“ prescelti per inserirvi un progetto espositivo – indica quanto tale zona di una memoria miserabile e pezzente, abbandonata a se stessa dopo l’esercizio, si configuri ormai come il confine ultimo, oltre il quale è necessario spingersi per modificare il nostro rapporto tra la retorica di un passato recente e l’intimo universo individuale e inconfessato/inconfessabile dell’immediato. La transmutazione da luogo di spaccio e scambio commerciali a luogo d’arte, il varco dell’esposizione in un simile sito assumono i lineamenti di un gesto catartico, di trasfigurazione individuale e – principalmente – di affinità connessa alla forza mnemonica infusa dallo spazio medesimo. Dall’azienda famigliare al salotto ideale di una casa borghese, elevato a giardino delle personali delizie o più precisamente a vivaio semiologico; un orto di segni e di segnali.
Oltrepassare quella famigerata linea tra la realtà e la finzione, il detto e il non detto, tra l’effettivo e l‘utopistico, tra il reale e il riflesso, tra piacere e dolore [e piacere ne/per il dolore], tradizione e modernità, tra ragione e psiche. Arte e arte applicata. Tra l’ordinario e l’extra-ordinario, oltre il possibile, oltre il conosciuto e il conscio. E la conseguente sparizione dell’arte come oggetto.
Nell’era della dematerializzazione tecnologica, della società immateriale e del materialismo dei valori, cui certa produzione artistica non vuole sottrarsi, ma che ci sottrae violentemente al reale e alla sensorialità materica, questo luogo trascende la sua fisicità per trasfigurarsi in luogo ideale; una sorta di interfaccia intimista/individuale per un pubblico catodico/televisivo, sociale, collettivo, illuminista e ben istruito per visitare manifestazioni d’arte. La scelta delle opere non è specificatamente tematica – bensì l’impegno curatoriale –, poiché i principi basilari di questa Inszenierung, di questo “teatro delle ossessioni o della psiche”, non incontrano forzatamente l’arte, e soprattutto non si sposano imprescindibilmente con essa o con la sua lettura più retorica e ufficiale. Ho messo a confronto lo spettatore, come modello comportamentale, con una maniera altra di concepire una mostra d’arte, essendo il percorso visivo più psicologico, personale e introspettivo, che di tipo fieristico. La scelta delle opere non è specificatamente tematica, se non il tentativo di renderle tali nella loro interazione con lo spettatore, una sorta di allontanamento dal “fare esposizioni”, dall’uso del “vedere mostre”, un ribaltamento, riflessione e indagine sul sistema dell’arte attraverso concetti quali la museologia, curatela e allestimento.
I criteri dicotomici e di bipolarismo qui racchiusi e sviluppati progettualmente portano in seno la condivisione con il visitatore anche di quei significati enigmatici, che sottintendono paradossalmente l’incontro perverso e piacevole di due punti focali opposti. Pubblico/privato, la reazione al collettivo, la presa di coscienza del sé, etc.
Quando Viana Conti ama insistere sul concetto di mise en abîme, si riferisce, per l’appunto, a questa possibilità di redenzione dell’uomo nel suo sofferto percorrere la via del proprio ritrovamento come introspezione e analisi centripeta nell’esplorazione.
Da questa viziosa riflessione si forma altresì il concetto di famiglia, teatro delle dinamiche legate all’introversione nel suo “essere“ ossessivo e assillante, ma paradossalmente sociale e mediterraneo nel suo “apparire”. Un’arena, ove si consuma il desiderio di incontro/scontro emozionale tra la vittima e il suo carnefice, e in cui si soddisfano vicendevolmente Bellezza e Tragedia, Castigo e Perdono, Seduzione e Dolore, ove avviene, nell’interazione, una interessante e pervertita sovrapposizione di oggetto e soggetto, o di soggetti altri. Il sistema crea pure comportamenti estatici nel loro congedo verso il metafisico e l’assoluto. Un vasto territorio della psiche, nel quale – come il giorno e la notte – si misurano, per l’appunto, “apparire” ed “essere”, pubblico e privato, evoluzionismi e creazione curatoriale, e laddove quei sistemi di lettura meno tradizionali della produzione artistica e maggiormente legati a una necessità dell’anima restituiscono allo spettatore un suo proprio modello interpretativo, la “sua” libertà di (auto)identificazione e conseguentemente il “suo” capitale (ri)conoscitivo oppure inibitorio.
L’ambientazione immerge il visitatore all’interno di un’opera contestuale, nella reciprocità con il tutto e specificatamente con l’arte, stimolando così in chi “cerca con lo sguardo” un particolare contegno comparativo con la propria – anche intima – individualità. È un luogo dove Dramma e Poesia si accoppiano, un luogo poeticamente incantato del bacio arrendevole tra Piacere e Repressione, di morte e di (ri)nascita.
Nel Leaving Room – cui fa da anticamera una sorta di “vestibolo”, un disimpegno al piano terra – i lavori sono installati alle pareti, quadri e disegni, vecchie fotografie – o recenti –; sui tavolini di questo grande soggiorno borghese sono posati oggetti e televisori, entro cui scorrono immagini di telecronache d’arte, oggetti e giocattoli sul pavimento e negli armadi. Divani e poltrone. Uno specchio, quello stesso elemento che riflette l’opera e il visitatore dell’opera che vede se stesso visitare l’opera.
[I criteri alla base di questa mise en scène, e – in senso più ampio – della commedia artistica, intendono rievocare egualmente altri ambiti da cui non sfuggono rimandi simbolico-teosofici. Se in tempi non troppo remoti, all’artista era destinata la terra sconsacrata, prima ancora la rappresentazione rientrava nelle leggi del proibizionismo, poiché il simbolo costituisce già una rappresentazione. Dissacrante appare la sala, oggetto dei sensi e della ratio individuali, ma assoluta e metafisica.
Senza riflettere necessariamente una cronologia temporale relativa a passato e futuro, ma lasciando al visitatore/lettore l’onere dell’incastro storico, l’intento è di restituire libertà alla creazione artistica, come azione corruttrice, (auto)liberatoria e di ricostruzione, causa ed effetto di un processo in continuo movimento. Un’impronta più apocalittica, infatti, vede parallelamente nella fine e nel superamento degli stili, delle forme, delle tecnologie, del “tutto è già stato detto” e dell’apogeo, una sorta di arrivo, di baratro, di perdizione totale e di fine di ciò che ha fallito nel travolgimento della Verità Assoluta in termini più mistici. A una visione positiva degli avvicendamenti storico-culturali, si sostituisce, quindi, un’altra maggiormente pessimista, che riconosce nell’evoluzione catastrofica o quantomeno catastrofista della Storia e dell’Uomo il nostro futuro: l’Apocalisse, appunto, poiché solo una verità superiore dispone di una conoscenza totale del tempo e degli avvicendamenti.]
L’avvenire sarà allora la costruzione dell’esperienza o la sua ricostruzione? Ecco che il concetto di Rivelazione potrebbe apparire come conseguenza patologica. La Bella e la Bestia. Rivelazione come Patologia dell’Apocalisse.
Erroneamente la produzione contemporanea sembra subire gli stessi presagi e quando si crede nella sua ormai prossima fine, quando si crede di possedere la consapevolezza che essa possa essere ormai arrivata al capolinea, il superamento di quella famosa linea di confine, dell’apogeo quale inizio di decadimento, rimettono in discussione l’evoluzione e il concetto di ciclicità storica. Apocalisse o Rivelazione? L’arte ha in sé questo potere sciamanico illimitato, escatologico, e di anticipatrice degli avvenimenti della Storia. Apocalisse è Rivelazione o quantomeno una non esclude l’altra.
[Secondo una concezione più teosofica, l’esigenza di ricercare l’essere ideale, perseguendo razionalità e analisi, è, invece, ampiamente superata dal concetto di “essere metafisico”. In totale contrapposizione agli psicologismi [vera piaga dissacrante dell’epoca moderna-contemporanea], si forma una convinzione più ontologica che predice un’analogia, una compatibilità, tra l’essenza divina e quella delle creature; di nuovo la ricerca di un archetipo, di una verità assoluta, comune e comunitaria. Al di là dei linguaggi utilizzati per significarla e al di sopra di noi.]
Il sistema crea comportamenti
[…] Il pleut. Les marquises sont devenues grises. […]
Sintomi e intuizioni per La Bella e la Bestia
Ogni osservatore ha la sua propria consapevolezza – anche quella di capire di non capire –; e ciò si verifica nella misura in cui egli non sia in grado di elaborare e quindi superare – come suggerisce Palazzoli – ciò che vede realmente o suppone di vedere e capire, identificandone o attribuendogli significati e valori.
Se la società tecnologica è riuscita a mettere in atto una manipolazione della realtà e del mondo delle percezioni umane, a tal punto da far esplodere la piaga fasullamente mistica e oppiacea di passivizzazione dei popoli di fronte alle tecnologie [una sorta di illusione della realtà o di realtà invisibile], e di controllo delle masse [una sorta di fondamentalismo tecnocratico-finanziario] – poc’anzi si scriveva, tra l’altro, di “estetizzazione” e “spettacolarizzazione” dell’informazione e dell’immagine –, parallelamente essa ha pure creato e incoraggiato la nozione di “bellezza formale”, di modelli da imitare, di consumismo o di fenomeni ormai planetari di aggressività collettiva: risultato di un evidente svuotamento emozionale e spirituale dell’uomo nella sua pratica di sottomissione alla macchina.
In un simile territorio del controllo, tutto potrebbe essere, così come tutto potrebbe essere il suo contrario.
Mi riferisco al mondo della televisione, a quello telematico, all’universo comunicazionale e comunicazionista via cavo telefonico o – ancora peggio – via satellite, a Internet, a tutti quei mezzi tecnologici che potrebbero condurci per riverbero a una visione distorta della realtà o semplicemente immateriale e impalpabile. Con una velocità effimera. La restituzione, oggi, di un’immagine, potrebbe rivelarsi un surrogato, una copia, a sua volta copia delle tante possibili copie dell’originale, riproducibili così all’infinito.
Ecco aperto il dibattito sulla “matrice”.
Riguardo al drammatico pessimismo attorno al sostituirsi della tecnologia all’uomo, è interessante quanto scrive Giorgio Piccinini a proposito dell’opera di due artisti.
[…] …certo è un percorso intrapreso già da diversi artisti, palesemente da Stelarc e Marcel-li Antunez Roca, ma penso che la filosofia sia di segno opposto, cioè oltrepassare la natura biologica per portare l’uomo oltre. Per il primo la passività davanti alla macchina diventa una scomposizione del corpo e la sua apertura a sistemi robotico-computerizzati in una interazione bio-meccanica […], ma sempre sotto il proprio controllo fisico-mentale, mentre per Marcel-li l’intervento esterno del pubblico attraverso la macchina nelle dinamiche della manipolazione del proprio organismo, può essere anche interpretato politicamente come evoluzione del concetto di critica al corpo borghese, inteso come egoistica proprietà e per mezzo della perdita dell’autodeterminazione attraverso la collettivizzazione di movimenti indotti da altre menti su materiale biologico, che non è più solo personale. Sul tutto certamente iniziano a porsi quesiti intorno al concetto di identità, sofferenza psicofisica, fino alla estrema possibilità di “autodistruzione” indotta, ma inconscia. Etc. […] (6)
E ancora Piccinini aggiunge:
[…] Naturalmente le interpretazioni sul lavoro di Marcel-li sono tante e tutte più o meno plausibili con diverse sfumature, come lui ebbe a dire sul legame col pubblico, che paradossalmente è l’interprete dell’azione teatrale: “Si crea un dilemma etico, perché state manipolando un essere umano e, in realtà, gli state causando dolore. Io non sono sadomasochista. Ci sono in ballo questioni più importanti: la spersonalizzazione delle relazioni umane, il confine indefinito tra sesso e potere, e l’uso del computer come strumento di controllo…” […] (7)
Orson Wells e La guerra dei due mondi, Franco Vaccari con la sua lungimirante Esposizione in tempo reale n° 4 dall’eloquente titolo Lascia su queste pareti una traccia fotografica del tuo passaggio, realizzata per la XXXVI Biennale di Venezia del 1972. Il suo inconscio tecnologico. Il controllo delle masse, la sofisticazione storica e il conflitto tra “opera d’arte” e “prodotto artistico”.
Sono evocatori le prime avvisaglie e i moniti di Vaccari registrati e qui riportati da Daniela Palazzoli.
[…] Una delle Esposizioni in Tempo Reale più esilaranti è Il cieco torna subito o Der Blinde kommt gleich, che è stata realizzata a Graz in Austria nel 1973. Ispirandosi ad un mendicante non vedente che chiedeva la carità alla fermata dei tram vicino al Museo, Vaccari crea un video in cui viene filmato solo il vecchio cappello del cieco. Il video, proiettato al posto del mendicante alla fermata del tram, coglieva di sorpresa i passeggeri, forse solo stupendoli (senza mai indurli a fare la carità al televisore). L’intento programmatico di questa precoce riflessione sul rapporto fra realtà “vera” e “virtuale” era e rimane quello di indurci a fare i dovuti confronti fra ciò che si vede, ciò che non si vede, e ciò che, in base ai modi in cui vediamo, riusciamo a definire come significato e valore di un’opera per ognuno di noi. […] (8)
L’arte, a prescindere dal mezzo impiegato per darle voce e forma, e dai suoi linguaggi, è un atto di resistenza a ogni tipo di svuotamento. L’opinione, risalente agli anni ’70, di Marshall McLuhan sulla relazione tra creazione artistica e tecnologia, rilanciava e ribadiva la sua convinzione che l‘arte potesse costituire un potenziale archetipico e ontologico, una sorta di antidoto-verità, un’idea ideale, non idealistica all’interno del dibattito attorno a realtà e mistificazione, e mirata all’autenticità sociale e antropologica dell’“essere umani”.
Marshall McLuhan, nel suo libro The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man (1962) ragiona sulla nascita della stampa come anticipazione delle tecnologie dell’oggi, ipotizzando un quasi isolamento dei sensi e – conseguentemente – di una scemata presa di coscienza in ambito creativo. Nella inarrestabile proliferazione tecnologica, egli considera(va) l’Arte come counter-environment, cioè un antidoto al contesto che faccia capire all’uomo il contesto stesso, attribuendo altresì alla creazione artistica una notevole importanza per quanto riguarda la formazione, e lo sviluppo del giudizio e della percezione.
E Jean-Paul Thenot scrive:
[…] Oggi, forse davanti a un nuovo Rinascimento, ogni artista, trasformato nel suo ruolo e nel suo statuto sociale, deve prendere a modello Leonardo, transdisciplinare ante litteram, al tempo stesso stratega, pittore, musicista, pensatore, architetto e filosofo. Siamo coinvolti nell’enorme salto che la nostra specie compie sul cammino del virtuale.
L’interiorità dell’essere, ai nostri giorni, può venir sovrastata dall’economia e dal sapere, nel momento in cui ogni nuova invenzione facilmente si riduce in semplice manipolazione. Bisogna resistere alla virtualizzazione, concentrarsi su territori e su identità a rischio o tentare piuttosto di affrontare il problema dandogli un senso, inventando, in breve, una nuova arte dell’alterità e del comunitario? […] (9)
[Thenot dimentica di citare la finanza, oltre l’economia, come fenomeno di dematerializzazione delle nozioni di ricchezza e valore correlate a quello di operatività lavorativa.]
Le tecnologie e la sublimazione tecnologica si sono trasformate, come esortava McLuhan, in messaggio. Esse riflettono, tendenzialmente, l’ambizione di perfezione dell’uomo e via via di maggiore – quanto viziosa – perfettibilità, rendendo sempre più sottile il “fare” e trascinando anche le arti nel vortice di un consumismo estetico.
Se dal “sublime tecnologico” l’uomo dalle caduche caratteristiche sarà tentato, il superlativismo della macchina avrà un effetto inibitore di qualsiasi caratteristica e peculiarità umane. Egli si raffronterà sempre più al congegno meccanico e sarà da esso sedotto, al punto da indurre una sovrapposizione uomo/macchina, se non una sottomissione ad essa. Questo potrebbe essere il dramma finale di una volontaria privazione della propria volontà, l’incontro dell’artificio con l’uomo e con la sua secolare ambizione di perfezione: un gesto autocratico di auto-sterilizzazione, l’incontro – appunto – estatico e ultimo tra perseguitato e persecutore. Se l’infinito universo delle emozioni riconduce al corpo e alla materia, quello non meno finito del concetto ci accompagna verso la sterilità di un linguaggio tecnico e troppo concettuale.
Credo si possa affermare che alla caduta e all’esaurimento delle avanguardie storiche [non della Storia come faro] faccia seguito la comparsa del concetto di arte contemporanea, priva, talvolta, di rigore e sobrietà; un infinito e snervante periodo di ricerche apparentemente disordinate e contrapposte alla Storia stessa, riassunte nel dogma della globalizzazione, della multimedialità dei mezzi e dei linguaggi, amorfo e talvolta privo di proprietà.
Ripensando alla nozione di Apocalisse, come Rivelazione e/o ritrovamento fors’anche patologico di un inevitabile e auspicabile percorso che ci riporti al Tutto o a un archetipo della verità, il quesito posto da Jean-Paul Thenot per il recupero di un valore transdisciplinare e “altro” della creazione artistica, e della figura dell’artista, sembra indovinato. Sicuramente anche come risposta alle attuali tendenze verso la privatizzazione, industrializzazione e massificazione dell’arte, e a tutti i suoi codazzi: Diktat della neo politica culturale/elettorale contrapposta al concetto di verità, essendo passati da una sua visione sociologica e antropologica a un’altra capitalistica, illuministico-funzionale, inutilmente socialistica e sulla via della decostruzione della conoscenza e delle coscienze. O forse solo del concetto di individualità.
McLuhan pone, però, anche domande fondamentali sull’opportunità della virtualizzazione. In epoca di multimedialità, di avvento delle tecnologie telematiche e dell’arte elettronica come inesorabile azzeramento del rapporto spazio/tempo, il concetto di qui e ora annulla a priori una qualsivoglia presenza dell’umano autodeterminantesi, se non quella preponderante e prepotente della macchina, unico vero medium che seduce l’uomo con l’idea dell’ubiquità. Essa [la macchina], per definizione, crea duplicati perfetti e sempre ancora perfettibili, mai originali. La concezione di “pezzo unico” e, appunto, “originale” – relativamente, in senso lato, alla centralità e unicità dell’uomo – viene meno, sostituendosi a quello di riproducibilità dozzinale e digitale, quindi senza identità materica.
Con lo sragionamento della realtà e partendo dal punto di vista, poc’anzi evocato, della passivizzazione dell’uomo in ginocchio di fronte alla società del capitale e del potere massmediatico/tecnologico, forse sarebbe auspicabile una necessaria oscillazione reattiva/reazionale tra apatia ed estremismo; segnale, quest’ultimo, di rivendicazione e di riappropriazione, fors’anche con accenti più marcanti, di giusti codici comportamentali e di identificazione.
[…] Pour parler du temps nous employons un vocabulaire propre à l’espace et, plus spécifiquement, au mouvement dans l’espace: le temps révolu et “passé”, il est “derrière nous”, etc.; le futur est “devant nous”, il “vient” ou il est “à venir”, etc. […] (10). […] Le temps est un résultat. C’est la résultante de l’action des autres. […] (11)
Da cui si deduce, secondo Recanati e Latour, che il concetto di tempo si definisce parallelamente a quello di spazio reale e conseguentemente di materialità e matericità.
Ritornando su i passi e le esortazioni indicati da McLuhan, l’arte potrebbe quindi ancora costituire un’espressione valida come contro-contesto o contro-cultura; un linguaggio espressivo che riconfermi la centralità dell’uomo e la sua verità spirituale – non necessariamente mistica – e rivelatrice.
Ad azione (con)segue reazione e contro-reazione, anche nel loro non sempre regolare riprodursi all’interno della reversibilità storica. A suffragio della tesi, secondo la quale l’informazione sia quasi interamente sottoposta a un processo di estetizzazione espressa con la sterilità del linguaggio tecnico – cui si riferiva Pasolini –, la cronaca degli ultimi anni ci insegna, per esempio, che la diffusione di una notizia abbia un maggiore impatto comunicazionale dell’informazione stessa [o altri modelli], come del resto la posizione McLuhaniana aveva anticipato: e cioè che il “mezzo” (tecnologico, massmediatico e informazionista) avrebbe prevaricato sul “messaggio”, lo avrebbe sostituito o quantomeno si sarebbe anteposto ad esso, allontanando e rimpicciolendo sempre più lo “spettatore” passivo, co-autore remoto.
L’antidoto che potrebbe far capire il contesto [più che altro il sistema], con tutti i suoi assurdi paradossi, è proprio il contro-contesto o la reazione. Alle tecnologie e alla strumentalizzazione tecnologica, al classismo artistico/culturale. All’estetizzante sublime tecnologico e all’effetto placebo.
La ripresa di alcuni criteri dei movimenti artistici degli anni ’60-’70 (ma anche di altro Novecento) non è casuale. Del resto nulla lo è, non solo in arte, bensì causale. Le scelte sono disparate, e la felice impotenza dell’oggi non riesce ancora a creare delle solide basi storiche per il domani.
Tuttavia, il tentativo di tornare all’arte pittorica, per esempio, e anche a temi fortemente legati all’identità/corpo, e a diversificati codici d’identificazione nella società contemporanea, sono ormai da qualche tempo una realtà. La rivisitazione di movimenti storici quali Body Art, Azionismo e altri performativi come il Punk visuale, o per una branca estesa Queer Punk e altro, non è più un fenomeno circoscritto a un’unica geografia storico/culturale, bensì riconducibile a un più ampio omogeneo gruppo reazionario e di resistenza: quella geografia mentale e psicologica che vuole rafforzarsi attorno alla propria esistenzialità riscoperta attraverso il corpo, la sessualità e la loro mortificazione come atto di sublimazione, di liberazione artistico/creativa, attraverso linguaggi multimediali, non solo mezzi.
Un possibile ritrovamento
È legittimo, o quantomeno pensabile, affermare che la nostra sia una società post-illuminista o post-illuministica, imputabile di aver volontariamente assunto un’identità di fredda organizzazione funzionalista, di cose e di uomini, svuotando cose e uomini della loro spiritualità? Così come di aver via via sistematicamente alterato l’uomo in pedina all’interno di un apparato sempre più funzionariale?
Il regime dei ruoli nasce da una precisa logica delle competenze, mirato alla creazione di un sistema di potere che nega l’individualismo e l’individualità, per mezzo di meccanismi che astutamente governano i loro tentacoli. Da sempre questa forma influenza la Storia e la lettura dei suoi significati; e dei suoi moniti. La creazione di un sistema di sistemi informazionisti, attraverso network televisivi o telematici, non ha prodotto collettivismo, quanto piuttosto globalismo. Se la classe politica ha finito anch’essa per assoggettarsi al potere economico/finanziario, l’individuo è stato senza dubbio da sempre vanificato. È un tentativo che ricorre spesso nella realtà dei poteri o dei sistemi di gruppo soggiogati al capitale.
A tale stato di cose vanno aggiunte le tecnologie, strumento che ci separa dal reale, o il concetto di intelligenza artificiale – realtà terrificante –, vero strumento del sistema sostenuto dal sistema. L’immaterialità, l’irrealtà e la simulazione rendono ancora più difficile oggi disegnare un identikit, dovendo definire la fisionomia, dei dominatori e dei dominati.
Il vincitore scrive la Storia e il sistema se ne (ri)appropria, riadattandone i contenuti. Ed è proprio in tale contesto che le tecnologie rivestono una importanza per la loro natura mistificatrice, assumendo inevitabilmente anche quella identità gattopardesca di strumento di controllo e propagandistico atto a cambiare tutto per, in definitiva, non cambiare nulla.
Come testé evocato, ecco riaperto il dibattito sulla “matrice”, quella stessa che, per equazione, sta all’uomo, così come l’artificio sostituirebbe l’originale: la volontà di realizzare una sorta di “soluzione finale” della cognizione, della conoscenza, della riconoscibilità, della volontà e dell’umanesimo.
La ricerca del sé, e della consapevolezza dell’uomo nella sua umile fusione con il tutto, necessita di una importante costruzione. Ritrovarsi è salvarsi. Disquisire sul concetto del sé – o quantomeno deciderne e/o accettarne la reale essenza – equivale anche a ribadire semplicemente il percorso esistenziale/esperienziale dell’essere umano (meglio descritto dai termini tedeschi Erlebnis e Erfahrung) nella sua eterna, universale e grandiosa solitudine.
A proposito di Body Art e di Storia, Luigi Meneghelli ancora scrive:
[…] Si è spesso associato la Body Art ai riti propiziatori primitivi: e senza dubbio, l’accostamento, almeno a prima vista, è calzante, perché l’uomo primitivo non ha una storia e l’uomo moderno non ha più storia. […] … il bodyartista con la sua “performance” non rimanda ad “altro” che a se stesso… […] (12)
[Dialogherebbe quindi la tecnologia con se stessa?]
Quando Viana Conti insiste sul concetto di mise en abîme, si riferisce alla possibilità di redenzione, difficile e sofferta, dell’uomo nel suo cammino verso il proprio ritrovamento, un sentimento rivelatore della propria identità individuale. L’essere.
E ancora: realtà “vera” o “virtuale”, come sembrava chiedere Palazzoli? E l’assenza di una identità storica definita dell’uomo contemporaneo potrebbe anche rivelarsi finalmente e a sua volta un potenziale storico?
L’innominato, ossia il luogo d’arte… Ricordandomi di quanto scritto sul sistema, mi chiedo a cosa serve un luogo d’arte. Perché un museo? Perché rinchiudere la memoria storica e quella attuale attraverso le arti all’interno di una sorta di riserva, allorquando, contemporaneamente, il pensiero creativo si palesa in controtendenza con il concetto di villaggio globale e di abbattimento degli spazi reali?
Un luogo d’arte è un luogo del potere, un baluardo di/per chi dispone, organizza e subisce più o meno piacevolmente i tasselli di un sistema. Ad esso decidiamo di appartenere, oppure in esso potrebbe esistere una perversa e conflittuale condivisione di interessi pubblico-politici e privati. È anche un luogo geografico, architettonico definito… non un Museo senza pareti (Museum Without Walls)…, al cui esterno all’arte stessa verrebbe attribuita – paradossalmente – minore importanza. Un luogo del potere che contribuirebbe a sancire i prezzi dell’arte, e in cui potrebbe manifestarsi la figura del curatore aziendale, il quale trasforma e vanifica i valori, crea neoalchimie all’interno del raffronto – per l’appunto – valore/denaro. [Il territorio espositivo ha da anni assecondato, più o meno consapevolmente, una visione mercantile della produzione artistica, creando ad arte un classismo a più velocità: apparire dentro il sistema o esserne fuori. In tal senso il curatore non può sottrarsi alle sue responsabilità.]
Ora, immaginiamo un luogo d’arte, che, per la sua impostazione curatoriale o per la sua caratteristica morfologica, conduca lo spettatore pressoché verso una rinuncia (in)consapevole della sua funzione di lettore obbiettivo e consueto. Avrei tanto voluto definire l’invisibile, dire il non detto, trovare le metafore o allegorie che sempre mancano, fare il museo senza pareti, affinché ciascuno di noi potesse ritrovare e rispecchiare se stesso nel dialogo delle opere. Una propria identità, scavando senza interessi, né artificio, con lo sguardo nelle immagini circostanti. Le opere artistiche, l’impianto curatoriale e lo sguardo del pubblico come abominevole ma verace specchio di una realtà invisibile, avendo noi il dovere professionale, sì, di non leggere l’arte esclusivamente come deviazione, ma anche il diritto di utilizzarla come necessario agente deviante. Un luogo, dove l’arte si è avvalsa solo marginalmente del concetto di prodotto artistico di consumo, laddove il tempo di una vita si riassume, restituendo al tempo stesso il suo giusto decorrere.
L’inquietante e apparente normalità della rappresentazione di un contenitore che ospita opere d’arte, rivisitazione metaforica del “salotto borghese” con attinenze piacevolmente vittoriane, mette senza ombra di equivoco lo spettatore di fronte a una molteplicità di temi e spunti di lettura, intimamente mentali; percezioni. Avrei desiderato che egli, il visitatore, riuscisse a decodificare se stesso, cedendo a un proprio singolare e individuale meccanismo (il)logico e psicologico del leggere e quindi del comunicare se stesso con “l’altro”, cercando di sondare i congegni inibitori oppure liberatori del pubblico e dell’artista.
La Famiglia. The Leaving Room vuole in qualche maniera dare un segnale per una creatività post-contemporanea. Il ritorno a messaggi e a valori etico/morali segnati dall’autore al di fuori di un sistema artistico/comunicazionale e/o evoluzionista, etc… In un certo senso ho voluto semplicemente ribadire il concetto di “riconoscibilità” dell’opera d’arte quale reazione agli ismi degli ultimi decenni e al di là di criteri della sua presentazione museologica.
In questo senso una nuova impostazione curatoriale potrebbe essere d’aiuto dentro spazi desueti.
Non a caso i creatori dell’oggi, o gli oppositori di ieri, ricercando una visione archetipica nel magma multimediale e tecnocratico contemporaneo, tentano di avvicinarsi a un pensiero rivelatore che superi l’opera, anziché cedere a una visione apocalittica. Ecco riesposto il quesito attorno alle responsabilità dei luoghi d’arte, essendoci posti ancor prima la domanda: a cosa serve la cultura attraverso le arti? E ancora, le arti stesse o altri ambiti quali la filosofia o la storia possono ancora insegnarci a migliorare noi stessi e la società?
Così, l’uso della tecnologia, della macchina e del corpo, vengono riassunti e messi in atto da Valter Luca Signorile. Il messaggio ci conduce al mezzo, e non viceversa.
Jerusalem #1, #2, #3 è una sua prima triade video sui significati attorno al corpo, allo spazio e alla ritualità o ritualismo. Sottile è l’intervallo tra situazioni intimamente sensuali e consapevolezze più collettive. Realizzati in maniera antiestetica per mezzo di un telefono portatile cellulare [anche strumento di immediata conservazione della memoria, per l’artista], le opere sono tre azioni senza pubblico, in cui l’autore-attore mette in scena se stesso (mise à nu) in un angolo di una stanza a me consueta (coin-coincé): pareti nere, pavimento quasi bianco. Egli è eretto e a piedi scalzi, mentre questa parte nuda del corpo rappresenta metaforicamente la purezza e l’incidenza del gesto, del passo progressivo o regressivo. Così come verace è tutta la realizzazione dei suoi video. Antiestetici, dicevo, per lasciare intatta quella bellezza assoluta, obbiettiva e universale nella sublimazione corporale dell’artista e nell’uso del mezzo, e concepita – anche – come desiderio di sottrarsi alla propria volontà individuale.
Attraverso gesti fisici altamente simbolici di invocazione, ma anche di imprecazione, l’artista si manifesta umilmente come medium tra la Terra e il Cielo, nella sua infinita, grandiosa, individuale e singolare concentrazione corporea e spirituale, quasi ipnotica e liturgica. Una ripetuta ritualità, che, attraversando spazio e tempo, gli consente di accostarsi in modo quasi mistico-religioso all’equilibrio interiore, ciò nondimeno comunitario, poiché l’ermetica universalità del gesto si traduce in egual modo in una concreta, quanto realistica, ed esternata presa di coscienza collettiva. Il linguaggio del corpo deoggettivizzato [nello specifico, una sorta di non-luogo carnale soggettivo] prevale sugli aspetti figurativi rimandando alla sublimazione della gestualità del corpo come linguaggio, all’origine, all’archetipo, ai precetti, alla verità assoluta e ontologica. Il Tutto.
La Famiglia. The Leaving Room è l’opera d’arte di un curatore, poiché trattasi solo della rappresentazione di un salotto borghese, nel quale vi sono altre rappresentazioni di altri artisti. Questo parallelismo voluto e provocato trova (s)punti di convergenza tra allestitore-osservatore e autore, suggerendo fors’anche contemporaneamente preoccupanti ed essenziali divergenze finalizzate all’esercizio del leggere. Le interdipendenze convergenti – o seducente bipolarismo – tra significato e significante, tra realtà e finzione, tra uso razionale o estetico del mezzo, e loro superamento irrazionale, rappresentano, in effetti, una delle molteplici ragioni d’esistenza delle visioni artistiche o arti visionarie.
The Leaving Room è la ricreazione (discreazione di un Living Room) di un’ambientazione domestica come luogo ossessivo di transito o di passaggio definitivo, un segno quasi catartico, liberatorio e trascendente, di transformazione del reale in visionario.
Similmente Signorile concepisce il luogo del tournage come stanza transfisica; metafisici sono i suoi gesti, i pugni che egli si batte sul petto o le mani che s’innalzano verso il Cielo. La sua mise en abîme dell’uomo Signorile sta nella ripetizione del gesto invocatorio, nell’ossessiva ripetitività come clonazione e assunzione delle tragedie del mondo.
Barbara et ses choix de vivre
Ça ne prévient pas quand ça arrive
Ça vient de loin
Ça c’est promené de rive en rive
La gueule en coin
Et puis un matin, au réveil
C’est presque rien
Mais c’est là, ça vous ensommeille
Au creux des reins
Le mal de vivre
Le mal de vivre
Qu’il faut bien vivre
Vaille que vivre
On peut le mettre en bandoulière
Ou comme un bijou à la main
Comme une fleur en boutonnière
Ou juste à la pointe du sein
C’est pas forcément la misère
C’est pas Valmy, c’est pas Verdun
Mais c’est des larmes aux paupières
Au jour qui meurt, au jour qui vient
Le mal de vivre
Le mal de vivre
Qu’il faut bien vivre
Vaille que vivre
Qu’on soit de Rome ou d’Amérique
Qu’on soit de Londres ou de Pékin
Qu’on soit d’Egypte ou bien d’Afrique
Ou de la porte Saint-Martin
On fait tous la même prière
On fait tous le même chemin
Qu’il est long lorsqu’il faut le faire
Avec son mal au creux des reins
Ils ont beau vouloir nous comprendre
Ceux qui nous viennent les mains nues
Nous ne voulons plus les entendre
On ne peut pas, on n’en peut plus
Et tous seuls dans le silence
D’une nuit qui n’en finit plus
Voilà que soudain on y pense
A ceux qui n’en sont pas revenus
Du mal de vivre
Leur mal de vivre
Qu’ils devaient vivre
Vaille que vivre
Et sans prévenir, ça arrive
Ça vient de loin
Ça c’est promené de rive en rive
Le rire en coin
Et puis un matin, au réveil
C’est presque rien
Mais c’est là, ça vous émerveille
Au creux des reins
La joie de vivre
La joie de vivre
Oh, viens la vivre
Ta joie de vivre (13)
Testo di Mario Casanova in La Famiglia. The Leaving Room, Edizioni neos.e, Genova, 2007, ISBN 978-88-87262-52-0
Note
(0) Giuseppe Desiato descrive la sua performance titolata Rito n. 1, 1964-65, tratta da Lea Vergine, Body Art e storie simili. Il corpo come linguaggio, Skira Editore, Milano, 2000.
(1) Urs Lüthi, citazione da A Few Mindflashes.
(2) Pier Paolo Pisolini.
(3) Giuseppe Desiato, descrive la sua performance titolata Rito n. 1, 1964-65, tratta da Lea Vergine, Body Art e storie simili. Il corpo come linguaggio, Skira Editore, Milano, 2000).
(4) Germano Celant, Artmakers, citazione, p. 31.
(5) Luigi Meneghelli, Shape your Body (verso il corpo astratto), in Shape your Body, Edizioni La Giarina, Verona, 1994.
(6) Giorgio Piccinini, da un suo scritto inedito del 29.01.2007.
(7) Giorgio Piccinini, da un suo scritto inedito del 16.02.2007.
(8) Daniela Palazzoli, Franco Vaccari: il cieco torna subito. Franco Vaccari: The Blind Man will be right back, in “Arte e Critica” n° 45, gennaio-marzo 2006, pp. 40-41.
(9) Jean-Paul Thenot, Jean-Pierre Giovanelli. Una poetica dell’essere, Edizioni Il Melangolo, Genova, 2006.
(10) François Recanati, in Les Immatériaux, a cura di Jean-François Lyotard, Centre d’Art et de Culture Georges Pompidou, Parigi, 1985.
(11) Bruno Latour, ibidem.
(12) Luigi Meneghelli, Shape your Body (verso il corpo astratto), in Shape your Body, Edizioni La Giarina, Verona, 1994.
(13) Barbara, Le mal de vivre, 1965.
Ph Alessandro Vivanti.
Dove
Ex Tiscanova
Locarno
Orari
Martedì – domenica
14:00 – 18:00